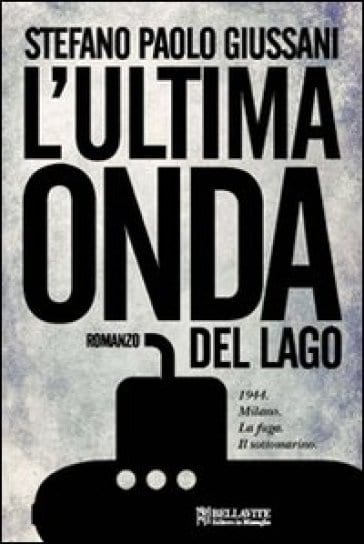Avete presente Alan Turing e il film The imitation game che racconta la sua storia ed è ora nelle sale?
Cinque anni fa vidi la macchina Enigma esposta al War Museum di Londra e mi colpì. Conoscevo la storia del matematico. E il trattamento che gli avevano riservato. Avevo anche sentito parlare del suo compagno Alistair. Così ho provato a immaginare un pezzetto di quella loro storia. Quello che non avevo immaginato è che dopo cinque anni dopo ne avrebbero tratto un film.
Se vi piace, potete diffonderla liberamente. Vi chiedo solo, per favore, di citare la fonte. Grazie.
ENIGMA (©2011 – Stefano Paolo Giussani)
Ad Alan Turing e Alistair Noon
King’s College, Cambridge, 1934.
Quel letto sarebbe stato normalmente troppo stretto per due persone. A vent’anni non sai ancora se preferisci stare vicino a chi dorme con te per scaldarti o avere lo spazio intorno per dormire allungandoti senza ostacoli. Loro erano di quelli a cui piaceva sentirsi vicini. Avevano l’abitudine di ascoltare il battito dell’altro tornare normale dopo l’amplesso. Al crepuscolo il più giovane sarebbe sgattaiolato nella sua camera in fondo al corridoio. Appena in tempo perché nessuno si accorgesse di nulla.
Stavano per ore affiancati così. Nudi. Con il sudore che raffreddandosi metteva voglia di stare più vicini l’uno all’altro. A cercare il calore della pelle dell’amico sulla propria. La stanza era rettangolare. Su un lato il letto. Di fronte un armadio e uno scrittoio sormontato da una piccola libreria. I libri, disposti ordinatamente, erano tutti testi di aritmetica. Un orologio era appoggiato su uno dei ripiani. Il suo ticchettio segmentava l’aria immobile del college. Il soffitto seguiva l’inclinazione del tetto, interrotta a metà da una grossa trave in legno. Per il più anziano, quella superficie spezzata era un puro esercizio geometrico. Un quadrato diviso in due rettangoli. Per il più giovane era invece una specie di finestra. Alla vista era chiusa, ma dietro quella grande anta in legno brillava un cielo pieno di stelle. Stelle che anche dalla finestra, quella dietro cui i rami del giardino balbettavano dal freddo, tremolavano con maggior intensità quando loro due erano assieme.
Alan era il matematico, Alistair il poeta.
È la nostra ultima notte assieme, disse Alistair sottovoce.
Chi può dirlo questo? rispose Alan come se stesse fissando qualcosa sul soffitto.
Lo sarà almeno per un po’. Parto per un giro in Europa.
Il matematico non se l’aspettava. Continuando a rimanere sdraiato girò la testa verso l’amico. Lo fissava infilarsi i boxer, la pelle raccoglieva il chiarore che filtrava dalla finestra e se lo spalmava addosso. Avrebbe voluto farlo lui. Quello in piedi si chinava a raccogliere le sue cose. La maglia, la camicia, le scarpe, tenute in mano. In quello stato di quiete notò che i piedi nudi facevano scricchiolare le assi nella stanza. La dita si distinguevano nella penombra sullo scuro del legno. Quando la porta si chiuse alle sue spalle, i passi nel corridoio schiaffeggiarono il pavimento mentre si allontanava.
Oceano Atlantico, HMS Garland, primavera 1942.
Sul ponte della corvetta inglese due ufficiali e un civile scrutano l’orizzonte. Non è una linea precisa ma un contorno sfumato reso incerto dall’acqua sollevata dal vento e spazzata come polvere. In lontananza si intravede il sole schiacciato tra nubi e mare. Riempie una linea infuocata tra due tavole color cenere che solo in certi punti assorbono la luce al giorno, si illuminano e vorrebbero incendiarsi.
Signor Turing, i nostri hanno iniziato a trasmettere. Ci affiancheranno entro pochi minuti. La voce del marinaio sopra di loro riesce appena a superare il rumore delle onde che sbattono sulla fiancata della nave. Gli ufficiali impugnano i loro binocoli puntandoli verso una unica direzione. Alan Turing ancora non distingue nulla e socchiude le palpebre per resistere alla raffiche di salsedine.
Dal centro della nave un gruppo di uomini si prepara a calare in mare una lancia. Un uomo in uniforme da ufficiale al fianco dell’unico in abiti civili gli indica un punto in mezzo all’oceano. Una luce. Sembra ancora lontana. La lontananza dell’orizzonte e le nubi basse non gli permettono di valutare la distanza. Negli elementi instabili del piano marino, tutto è precario. Non c’è verso di avere un fulcro nell’acqua. Sono colline liquide che si muovono alzando e abbassando la lancia ormai staccata dalla nave da guerra. L’unico punto stabile per Alan è la murata della corvetta. Sembra resistere indifferente all’acqua e al vento.
Il faro che prima era lontanissimo e spariva tra le onde, ora lampeggia tra gli spruzzi. Si avvicina.
Si distingue avanzare una sagoma scura. Fende la superficie rimanendo sul pelo dell’acqua. È un sommergibile. Il ponte è coperto dall’acqua, scivola indisturbato tra lievi colline fluide. Gli ricorda uno di quei grossi tronchi durante le mareggiate invernali, quando dalla scogliera si vedono galleggiare mentre lasciano passare sotto di loro onde grosse come montagne. Solo la torretta emerge dall’acqua mentre sulla sua cima si muovono mezzi busti di uomini. Si capisce che c’è una certa attività ma non si distingue cosa stanno facendo.
Ora le due navi sono quasi affiancate. Sul ponte della corvetta si sente un borbottio. È il motore diesel del sommergibile che a tratti gorgoglia sotto la superficie dall’acqua. È un rumore pigro che sfuma nei fischi delle raffiche del vento.
Alcuni dei marinai della torretta scendono sul ponte. Uno a fianco all’altro formano una catena e coprono la distanza fino alla scialuppa che adesso tocca il sommergibile. In balia delle onde e sospeso tra le due navi il motoscafo sembra ancora più piccolo. In certi momenti sembra debba essere ingoiato dalle onde, che però lo sputano subito dopo. Gli uomini si scambiano dei pacchi. Verso il sommergibile si distingue quello della posta. Alan pensa che probabilmente quegli uomini sono in missione da parecchio tempo. Una grossa scatola scende invece di mano in mano dalla torretta fino al motoscafo. È una cassa, distingue bene le assi che segnano la forma di un parallelepipedo. Gli uomini la appoggiano sul pavimento. Usano una delicatezza inusuale per dei marinai che ti aspetti abituati agli schiaffi dell’oceano, la trattano come se fosse un oggetto fragile. L’uomo a poppa piega con decisione la barra del timone e ridà gas al motore. Il piccolo scafo si allontana veloce per tornare verso la corvetta, come un bambino che ha fretta di scappare dal nuovo arrivato per tornare dalla mamma. Il tempo di fissarlo mentre spancia sull’acqua sotto di loro e Alan nota che anche il sommergibile è ripartito. È già lontano, al termine di una scia di schiuma che ribolle tra le onde infrante. Sta per scomparire, discreto come si era avvicinato.
Nel quadrato degli ufficiali la cassa è appoggiata sul tavolo. La sagoma regolare è illuminata dalle luci sul lato anteriore. Risalta sulla parete scura. Ha quasi l’aspetto di un altare all’interno di uno spazio sacro. Sacerdotale è anche il silenzio. Sul fronte della cassa una sola scritta: for intelligence use only.
Il comandante con un cenno della testa indica ai due marinai di aprire la cassa. Delicatamente, ragazzi. Da quel pezzo di legno dipende la guerra, dice loro mentre infilano le mani tra i legni. Le braccia nude si gonfiano mentre la estraggono. L’oggetto è pesante, esce lentamente dal contenitore.
Un telo mimetico avvolge una specie di macchina da scrivere. Ha una tastiera, ogni tasto marchiato con una lettera o una cifra. L’occhio immobile di un’aquila nazista nella parte superiore sostiene e ricambia lo sguardo di tutti. Ora è affar suo, mister Turing, aggiunge il capitano mentre continuano a fissare l’oggetto al centro della stanza. Alan si scambia un’occhiata con l’unico uomo che indossa un’uniforme diversa da quella della marina. Dev’essere dello stato maggiore.
Signori, ora potete lasciarci soli, dice l’ufficiale. Come Alan, anche lui dipende dalla Hut8. Sono criptoanalisti del ministero della guerra. Devono rompere il più grande segreto della marina tedesca. Il codice Enigma, il linguaggio cifrato con cui comunicano le navi di Hitler.
Quartier Generale Hut8, Bletchley Park, Autunno 1944.
I numeri sono dati oggettivi, non hanno bisogno di interpretazioni. Le parole sì. Hanno più di un significato. Una stessa parola cambia a seconda di come la pronunci o la ordini in una frase. Un matematico e un poeta, per questo, non potranno mai andare d’accordo.
Alan pensava questo prima di incontrare Alistair. Poi aveva scoperto che il cuore era una specie di denominatore comune che poteva far dialogare i due universi. Matematica e poesia erano diverse ma riuscivano a parlarsi.
Nel mezzo dell’oceano lui, il matematico diventato per necessità criptoanalista, si era trovato di fronte alla macchina che decifrava segnali. Ci aveva lavorato sopra da subito. Giorni e notti. Aveva imparato a prevenire le mosse del nemico. Raccoglieva informazioni. Salvava vite. Creava le condizioni perché ne finissero delle altre. Erano anche quelle addizioni e sottrazioni. La morte di un marinaio è una tragedia per una famiglia, l’affondamento di una nave con mille uomini è solo una statistica. Operazioni matematiche di guerra calcolate solo spostando carte e senza mai abbandonare l’edificio vittoriano tra le piante secolari nella campagna di Londra.
Da qualche parte sulla costa del continente aveva immaginato Alistair in una strada a combattere. All’inizio della guerra sapeva che lo avevano visto lanciare bombe tra le milizie popolari contro l’alziamento dei generali in Spagna. So bene che lotto per qualcosa che non durerà. Nessun futuro è per sempre, gli aveva detto il poeta prima di partire. Spesso sente ancora quelle parole, la voce dell’amico gli echeggia nella testa. Era stato il suo commiato appena prima di partire. Prima di uscire scalzo dalla stanza.
Io combatto per il mio passato, perché un po’ di me riposi intatto in quello che è accaduto. Era il suo modo per scendere in campo. Immediato, sanguigno, per lui era perfino naturale, come un verso di una poesia. Lasciar scorrere il sangue nelle vene fino alle mani. Lasciare che il fluido bollente le muovesse nel combattimento. Per questo si era unito a un gruppo di catalani.
La Catalogna, gli aveva scritto poi, è un posto perfetto per i poeti.
Ormai erano cinque anni che non aveva più sue notizie.
Nella stanza Alan è solo. È appena tornato da una corsa sotto la pioggia. Gli piace correre. Sulle lunghe distanze ha una buona resistenza. Lo aiuta a pensare. Lo aiuta a sfogarsi.
È completamente sudato. Si toglie la maglia fradicia e la butta a terra. La lascia a fianco alle scarpe nel centro di una pozza. C’é un tavolo nella stanza. In mezzo alle carte sparpagliate c’è una tunny. È una delle macchine del codice Enigma. Ormai le chiama con confidenza, le conosce fino all’ultimo degli ingranaggi. Il codice è rotto da tempo. Per questo alcuni lo chiamano “Il genio della matematica”. Il cono della lampada sul soffitto illumina l’apparecchiatura da sopra, senza lasciare ombre. È quella arrivata con il sommergibile nell’Atlantico, la prima trovata. Puzza ancora di carne bruciata. Ha letto poi nei rapporti che c’era stato un incendio a bordo della nave tedesca durante l’attacco. L’odore è forse di qualcuno che è morto vicino alla macchina. Immagina un giovane marinaio cresciuto sulla costa tedesca. Forse non gliene fregava perfino niente della guerra. O forse era un invasato del nazismo e ha difeso fino in ultimo il segreto.
Ogni tanto torna a toccare la macchina. Quando si muovono i tasti, i rumori metallici si susseguono in un incastro perfetto di suoni. Sono rumori affilati nel silenzio della stanza. Alcuni più lunghi. Altri più brevi. Dipende dalla lettera. Ogni volta che schiaccia avverte una sensazione strana. Come di irreversibilità. Alan riflette come sia impossibile cancellare la lettera originata dal suono. Battuto un tasto non è più possibile tornare indietro. A… B… segni che si trasformano in suoni e scivolano nell’aria.
La guerra sta per finire e gli hanno permesso di tenere la macchina. Ormai sono riusciti a prenderne altre. Poi, a lui è concesso. È quello che ha rotto il codice. Forse anche per questo alla Hut8 lo trattano con rispetto. Sono perfino disposti a dimenticarsi certi suoi comportamenti. Sanno che preferisce gli uomini alle donne. Almeno nel suo letto. Se ne sono accorti quando ha detto di no a Joan Clarke. Una collega, un’amica. Agli occhi di tutti poteva filare. Non ai suoi, non avrebbe mai potuto essere un marito. Almeno per ora non gli possono fare nulla, lui è quello dell’Enigma.
A… B…. Due lettere su due tasti. L’inizio dell’alfabeto e le prime due lettere decifrate dalla macchina. A come Alistair. B come Barcellona. Un caso? La matematica non lo ammette. Lui, ora, sì.
È tornato ancora da una corsa. Sul tavolo c’è una busta aperta. La lettera è arrivata in mattinata. È di un amico comune. Conosce il fratello di Alistair.
È morto. A Barcellona. Su una barricata della città durante un attacco dei generali. È successo il 26 gennaio del 1939. Son passati 5 anni. Ne erano già passati 3 quando Alan era in mezzo all’oceano ad aspettare la sua prima tunny.
Alan vuole piangere. Sente il dolce di una lacrima mischiarsi col salato del sudore sul labbro. Ricorda l’ultimo abbraccio di Alistair prima di uscire dalla stanza del college, quei passi nudi nel corridoio. Pensa alle guerre così diverse di un poeta e un matematico.